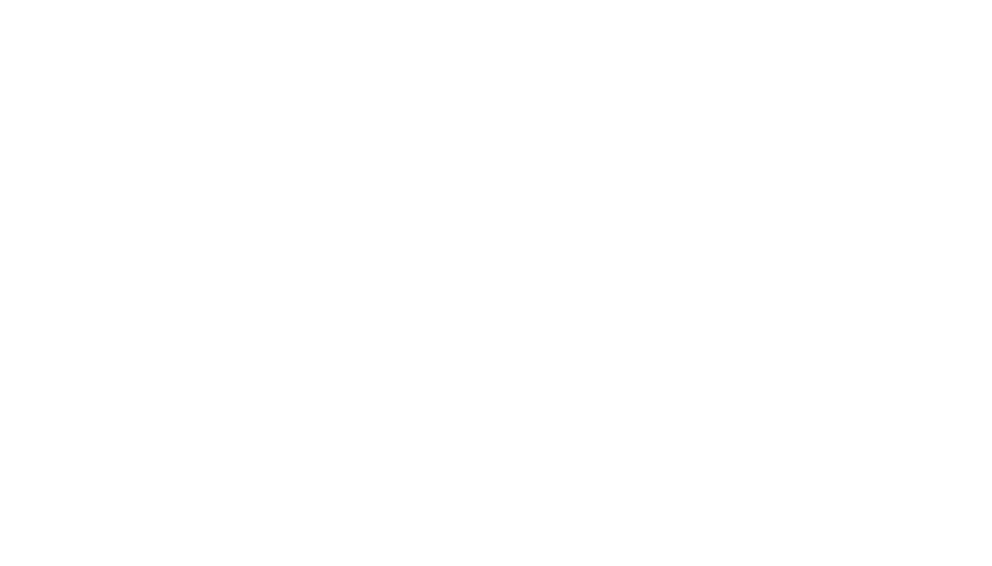Migrazione e salute mentale: il progetto EU-MiCare supporta professionisti e volontari
È stato occasione di un interessante scambio e confronto a Milano l’evento nazionale di chiusura di EU-MiCare, progetto triennale finanziato dall’UE nell’ambito di Erasmus+ e dedicato ai professionisti e volontari impegnati a lavorare sul benessere mentale di migranti e rifugiati.

Il 10 settembre 2025 si è svolto a Milano l’evento nazionale di chiusura di EU-MiCare, progetto triennale finanziato da Erasmus+ e dedicato a professionisti e volontari impegnati a lavorare sul fronte del benessere mentale di migranti e rifugiati. L’iniziativa nasce dalla crescente consapevolezza che la migrazione non è una crisi temporanea, ma una realtà strutturale che trasforma società ed economie. Come ha ricordato Maria Rosa Valetto – che con Eva Benelli ha coordinato i lavori per Zadig, partner italiano del progetto – la salute dei migranti può diventare un punto d’ingresso per rinnovare la solidarietà globale e rafforzare la copertura sanitaria universale.
Le tappe del progetto
EU-MiCare prosegue un percorso iniziato con il progetto EU-VET CARE, focalizzato sull’assistenza ai minori non accompagnati. In questo nuovo capitolo, l’attenzione si è spostata sulla salute mentale, con l’obiettivo di rafforzare le competenze di operatori sanitari e sociosanitari, ma anche volontari, counsellor, interpreti e mediatori culturali. Il consorzio internazionale comprende partner in Germania, Spagna, Grecia, Cipro e Italia, con il coordinamento dell’Ethno-Medizinisches Zentrum di Hannover.
Il lavoro è partito da una mappatura della situazione nei Paesi coinvolti, affiancata da focus group che hanno raccolto le esigenze di sessanta professionisti. È emersa la necessità di un’offerta formativa più strutturata e globale. Per questo il progetto ha sviluppato una piattaforma e-learning multilingue, gratuita e accessibile a tutti i professionisti e volontari, che nei primi quattro mesi ha coinvolto circa quattrocento persone. Il corso resterà online per due anni.
Il programma formativo combina conoscenze teoriche e strumenti pratici: schede di screening per l’individuazione precoce dei disturbi, protocolli di primo soccorso psicologico, linee guida per il lavoro in équipe multiprofessionali. Ampio spazio anche al benessere degli operatori, spesso esposti a stress e senso di inadeguatezza.
Voci ed esperienze a confronto
L’evento milanese ha dato voce alle esperienze e alle attività dei partner di progetto, così il gruppo tedesco Ethno-Medizinisches Zentrum ha illustrato il modello MiMi, che forma mediatori culturali e produce guide multilingue per facilitare l’accesso ai servizi sanitari: concepito sulla base dei principi di partecipazione sociale, empowerment e peer education, MiMi recluta, forma e mette in rete mediatori sanitari transculturali multilingue, che poi conducono campagne nelle proprie comunità culturali per informare sul sistema sanitario tedesco, sulle sfide sanitarie e sugli stili di vita sani. L’uso di cartelli e supporti informativi multilingue, lo sviluppo di reti sanitarie transculturali locali e la valutazione e la misurazione dell’impatto completano il quadro. In Germania il modello è stato applicato in oltre settantacinque località, formando 3.500 mediatori e realizzando più di 13.000 attività informative.
Lo psichiatra Nicos Gionakis ha sottolineato la necessità di non ridurre l’esperienza migratoria a etichette diagnostiche come il disturbo da stress post traumatico (PTSD) ma di considerare la complessità dei vissuti individuali, le condizioni di vita, il supporto sociale e le politiche di accoglienza. Gionakis ha parlato di “disorientamento nostalgico” per descrivere la perdita di riferimenti e di fiducia che segue alla rottura della stabilità, e ha invitato a riconoscere le risorse residue e la capacità di crescita che possono nascere dall’attraversamento di esperienze traumatiche. A questo proposito ha richiamato l’autorevole approccio messo a punto da Renos Papadopoulos, che considera l’esperienza migratoria nella sua complessità, unicità e totalità per vedere, oltre l’etichetta di migrante/rifugiato, l’umanità della persona e riconoscerla come protagonista del percorso di cambiamento della sua vita. In particolare, ha raccomandato di superare la visione limitata e limitante del migrante come portatore di PTSD, ma di riconoscerne vulnerabilità e resilienza facendo riferimento alla griglia delle avversità”.
Ampio spazio ha avuto la riflessione sul ruolo dei mediatori culturali, figure cruciali per superare barriere linguistiche e culturali, soprattutto nei centri di accoglienza italiani, dove non sempre è previsto un presidio psicologico. Preparare i richiedenti asilo al colloquio con le Commissioni territoriali, facilitare la comunicazione tra operatori e utenti e garantire condizioni di sicurezza culturale e di genere sono solo alcune delle funzioni che questi professionisti svolgono quotidianamente.
Hanno portato la loro esperienza Flavia Calò, psicologa e responsabile della salute mentale per il programma di Médecins Sans Frontières sui corridoi umanitari; Sofia Carra, studentessa di giurisprudenza e volontaria per l’assistenza legale ai richiedenti asilo, con Naga ODV; Irene Carrano, psicologa e psicoteraputa di Farsi Prossimo Onlus; Lorenzo Mosca, etnopsichiatra all’Ambulatorio Sociale per la Salute Mentale, Casa della Carità di Milano; Ludovica Oliva, ricercatrice dell’Università Luigi Bocconi, Clinica Legale Diritti e Vulnerabilità – Sportello San Siro e della Clinica Legale UASI, Ucraina – Supporto e Informazione; Elena Sacchi, mediatrice linguistica e culturale e operatrice legale, CAS Aquila di Milano e operatrice sociale, France Terre d’Asile, Parigi.
Le testimonianze provenienti da tutte queste realtà hanno portato esempi concreti di accoglienza in quartieri fragili, spazi dedicati alla privacy, gruppi madre-bambino e progetti specifici come i corridoi umanitari dalla Libia, che hanno già permesso l’arrivo in Italia di oltre quattrocento persone. Particolare attenzione è stata rivolta alle donne e ai bambini, spesso portatori di traumi transgenerazionali.
La giornata si è conclusa con una riflessione più ampia sul sistema dei servizi in Italia. Molti operatori hanno denunciato la rigidità delle istituzioni, accentuata dopo i decreti del 2018–2019, e la necessità di una maggiore collaborazione pubblico–privato. Senza una strategia nazionale coerente, le buone pratiche rischiano di rimanere isolate e la formazione degli psicologi non appare adeguata agli obiettivi della psichiatria transculturale.
EU-MiCare ha dimostrato che è possibile costruire percorsi di formazione condivisi, basati su esperienze concrete e validati scientificamente. L’auspicio, richiamato da Eva Benelli in chiusura dell’evento, è che questo progetto rappresenti non un punto di arrivo, ma il tassello di un percorso più lungo, capace di rafforzare la connessione tra salute, migrazione e inclusione sociale.